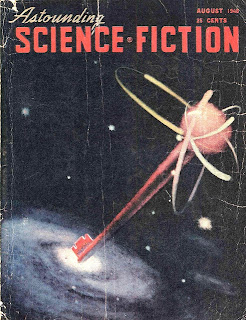Cor
Serpentis è un vero classico, con tutti i crismi della classicità. È
anche un’opera storica: nel senso di documento storico della sua epoca. Infine,
è un reperto della geopolitica del XX secolo, e in particolare dell’età
postbellica della Guerra Fredda.
La breve novella è una delle
opere più note del suo autore, il paleontologo e scrittore russo Ivan Efremov
che, se non il maggiore esponente, fu senza meno tra i nomi più importanti
della letteratura di fantascienza sovietica che fiorì dopo la II Guerra
Mondiale. Di quella vasta produzione, che fu sicuramente la più lontana dai
canoni della sf angloamericana che ha “colonizzato” (ormai non solo) l’Occidente,
dall’altra parte della Cortina di Ferro non giunse moltissimo. Ai patrii lidi italici
approdò comunque una significativa scelta di testi, tra i quali nel tempo si
segnalarono particolarmente i romanzi dei fratelli Arkadij e Boris Natanovič Strugackij, sia per il notevole livello del
loro lavoro, sia, probabilmente, perché i due Strugackij si posero spesso, e
sempre più col tempo, in posizione critica verso il sistema politico sovietico o
quanto meno tutt’altro che prona, mostrando nella loro scrittura una visione
critica e uno scetticismo vicini a quelli occidentali. Efremov fu invece fin
quasi all’ultimo un convinto assertore dei valori di un socialismo umanitario, o
forse di un umanesimo socialista, e la sua opera è attraversata da una
fortissima tensione verso una pace universale e una fratellanza tra le genti,
raggiungibile solo attraverso il compiersi di una rivoluzione socialista – una rivoluzione
del pensiero e dello spirito umani, è bene precisare. Una rivoluzione del modo
di essere degli uomini, il loro conformarsi a una visione solidaristica e
progressiva dell’esistenza, ed evolutivamente progressiva della storia, in una
prospettiva che si allarga all’infinito, senza limiti per questo Uomo Compiuto
se non quelli intrinseci delle leggi della fisica e della chimica. Un qualcosa che in Cor Serpentis si vede chiaramente.
 |
| La Nebulosa di Andromeda - seconda edizione italiana |
Come anche nell’opera più
significativa di Efremov, il romanzo La
Nebulosa di Andromeda. Pubblicato due anni prima di Cor Serpentis, a dispetto della relativa aridità dello stile e
della narrazione è il racconto filosoficamente affascinante di un utopia
socialista, e rilanciò la sf sovietica in virtù di un allargamento concettuale
e visivo a tematiche sociali e a un futuro lontano nel tempo, lasciando
(relativamente) in secondo piano quella rigida estrapolazione scientifica e
tecnologica che fu un po’ il marchio della fantascienza d’oltrecortina (e che
comunque Efremov tratta con l’abituale accuratezza). In Chas Byká, il suo
ultimo romanzo pubblicato in vita, e rapidamente ritirato dal commercio dalle
autorità, Efremov tornò all’universo narrativo de La Nebulosa di Andromeda, ma questa volta con toni e riflessioni
lontane dalla fiducia che aveva caratterizzato la sua passata produzione.
 |
| Prima edizione italiana della novella: 1963, Galassia n.26 |
Cor Serpentis è un autentico classico in primo luogo perché
appartiene al genere che più di ogni altro identifica la fantascienza nella
storia della letteratura e dell’immaginario: la Space-Opera. E al suo interno consuma un altro dei topoi assolutamente fondamentali e
identificativi della sf: l’incontro con l’Alieno. Un primo contatto, per di
più. Senza ridursi a fare un trattatello scientifico o peggio
pseudoscientifico, Efremov cura con grande attenzione i dettagli scientifici e
tecnologici del racconto, che non risultano semplici accessori ma sono una
cornice che dà senso al quadro narrativo ed elementi dinamici di essa,
fondamentali per dare il tono all’ambientazione filosofica della narrazione. Ad
appesantire quest’ultima sono se mai gli incisi più prettamente speculativi,
sociologici e didascalici (o propagandistici tout court), che spesso sfociano in vera e propria ingenuità o
utopismo illusorio. A riscattare questi passaggi a vuoto sono gli occasionali
squarci lirici che riescono a imporsi all’attenzione del lettore a onta della
traduzione da cani e della cura editoriale perfino più approssimativa della
traduzione. È attraverso tali intarsi, di un lirismo appassionato e naif, che trapela
la natura profondamente romantica dell’ispirazione utopistica di Efremov:
quando i suoi controllatissimi personaggi dismettono per un attimo la loro
attitudine, degna di manichini robotici, di perfetti esempi di Uomo Evoluto e
Compiuto, in essi si legge in filigrana qualcosa di più e di meglio del
pensiero di un convinto uomo di apparato: si vede un sognatore. Un sognatore
forse ingenuo come i personaggi a cui dà vita, ma sincero. E sicuramente
visionario, un ardito che ha spinto la sua immaginazione non tanto nelle pieghe
dello spazio e del tempo, quanto dell’uomo. Un utopista, certo, e probabilmente
un illuso che riponeva troppe speranze nelle potenzialità umane di sviluppare
una coscienza solidaristica; tuttavia questi nostri tempi in cui assistiamo,
quanto meno in Occidente, a una vera e propria morte dell’Utopia e dei suoi
sogni, ci mostrano come l’Utopia sia la linfa vitale dell’elaborazione e della
progettazione politica, sociale, filosofica.
 |
| Chas Byká, inedito in Italia |
È
difficile immaginare Cor Serpentis
scritto in un’epoca storica diversa da quella in cui fu effettivamente scritto.
La (relativa) rinascita del sogno socialista seguita alla denuncia della
politica staliniana da parte del nuovo leader sovietico Nikita Chruščёv inquadra la novella come una lettura
utopistica di quella rinnovata speranza che si originò dal voltare pagina
operato dal politico ucraino. E diventa facile pensare che la restaurazione
attuata in seguito dal cupo ordine brezneviano condurrà le speranze e la
visione gioiosa, l’aspettativa di un felice futuro di pace coltivata nella
novella a mutarsi nella visione critica del romanzo Chas Byká, che è del 1968. Cor Serpentis è innegabilmente un’opera
che contiene un intento propagandistico e didascalico, ma è ben lungi dal
ridursi a questo. Nella scrittura il linguaggio e l’animo di Efremov si
mostrano primariamente gioiosi. Il desiderio di un futuro di pace e di amore
per la conoscenza è palpabile nella sua sincerità, così come la convinzione che
questo possa avvenire solo con il compiersi del comunismo.
A questa genuinità
di pensiero va concessa l’ingenuità delle estreme semplificazioni psicologiche,
sociali e di proiezione storica che Efremov compie. Gli uomini e le donne
partiti dalla Terra per esplorare le profondità spaziali alla ricerca di
conoscenza, e con la speranza di incontrare altre razze intelligenti, sono
vuoti nella perfezione delle loro coscienze, nella purezza della loro anima,
nella completa equanimità della loro morale. E così dal momento che Efremov è
comunque troppo un buon scrittore per appiattire del tutto i personaggi senza
conferire loro dei guizzi di emozione e vitalità, umana e narrativa, tuttavia i
dubbi sollevati da Kari Ram o le velate suggestioni erotiche innescate da Afra
Devy - come anche l’ironia e le apparenti malinconie del comandante Muta Ang oppure
ancora la timidezza di Tei Eron – appaiono ulteriori dettagli atti a mostrare
una più ampia e meno superficiale perfezione umana ma non il suggerimento di un
dubbio dell’autore o di uno scavo psicologico fine alla descrizione di un
essere umano oltre al personaggio funzionale. L’equipaggio dell’astronave Tellur è composto di uomini e donne di
nuovo tipo, che possono avere occasionali e fugaci manifestazioni di un modo di
pensare arcaico (come Kari Ram), ma che in realtà li hanno solo in funzione di
offrire all’autore il modo di confutarlo. E del tutto speculari agli astronauti
terrestri sono quelli dell’astronave aliena, gli umanoidi che respirano fluoro
e con i quali non può esservi pertanto interazione fisica, ma con i quali ci si
intenderà perfettamente nella cornice di una fratellanza universale tra specie
senzienti che è l’approdo finale dell’utopismo universale di Efremov, del suo
umanesimo socialista.
 |
| L'autore poco più che ventenne |
 |
| Incontro su Tuscarora, Galassia 33 Una delle poche opere di Efremov apparse in Italia |
Cor Serpentis è un prodotto della sua epoca anche in
quanto prodotto della Guerra Fredda. È infatti noto come la novella di Efremov
sia una risposta, se non polemica certamente in antagonismo dialettico, al
racconto di Murray Leinster First Contact
pubblicato nel 1945. Il racconto leinsteriano, esplicitamente richiamato da
Efremov nel suo, è una delle migliori narrazioni sul primo incontro tra la
specie umana e gli alieni ed è tra le cose più belle di Leinster, uno dei
pionieri della fantascienza americana delle riviste. In First Contact, sebbene la conclusione possa comunque dirsi positiva
e ottimistica, l’evento del primo incontro della specie umana con una razza
aliena è senza dubbio dominato dalla paranoia, dal sospetto e dalla sfiducia
reciproci, e lo spettro della guerra è presente e reale. In contrasto con la
visione da Guerra Fredda di Leinster, Efremov vorrà sostenere che la paranoia e
il sospetto non potranno più appartenere a un’umanità approdata, attraverso la
logica dialettica del socialismo, a una maturità spirituale consapevole dell’appartenenza
dell’individuo e degli individui a una specie in pacifico e fiorente divenire,
storico e biologico. Una maturità che dovrà necessariamente appartenere a ogni
eventuale specie senziente dell’universo passata necessariamente attraverso le
stesse esperienze politiche e sociali dell’Uomo della Terra. Una visione che
forse ripone davvero troppa fiducia nella ragione umana, ma che tuttavia è
grandiosamente visionaria nel senso in cui dovrebbe sempre esserlo la narrativa
fantascientifica, volta all’esplorazione dei limiti umani e alla proposta dei
sogni indispensabili a nutrire la progettualità del futuro. Una visione che
forse è bene leggere come complementare e non oppositiva a quella fornita in
precedenza da Leinster.
La
prima edizione italiana di Cor Serpentis
apparve nel 1963 sul fascicolo n.26 di Galassia prima veste grafica, con il
titolo Il Cuore del Serpente. La
seconda e a tutt’oggi ultima ristampa per quanto mi risulti, avvenne quattro
anni più tardi in La Formula Impossibile,
quinto volume della collana Fantascienza Sovietica, con il titolo di Cor Serpentis. Il volume presentava,
come quasi tutti i fascicoli della collana, un’antologia di racconti, tra i
quali abbastanza sorprendentemente non è stata privilegiata la novella di
Efremov per la scelta del titolo, scelta che è invece caduta sulla più breve
novella di Evgenij L’vovič
Vojskunskij e Isaj Borisovič Lukod’janov. Nell’indice del volume l’autore è indicato
come I. Epremov, mentre nel corpo del
volume, alla pagina di presentazione della novella, esso figura come I. Efremov. Tanto per sottolineare che
se la traduzione era pessima, la cura editoriale era anche più fatiscente.